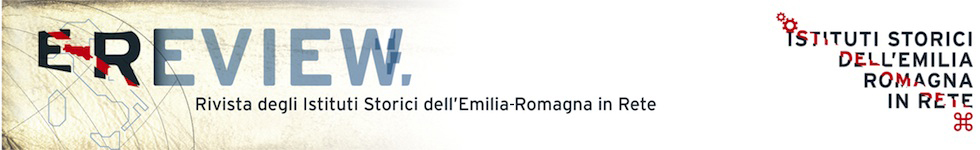Quando fa abbastanza buio,
puoi vedere le stelle.
Charles Austin Beard
Premessa
Una cooperativa di consumo è un’impresa con scopi commerciali (in genere nel settore alimentare e dei prodotti di uso comune), dotata di uno o più punti vendita, nella quale i proprietari, detti soci, sono coloro che prevalentemente vi fanno acquisti. Si tratta di una forma d’impresa quasi universalmente considerata democratica e intergenerazionale, con tratti mutualistici e solidaristici [Zamagni e Zamagni 2010]. L’avvio del moderno movimento cooperativo è fatto risalire proprio alla fondazione di una cooperativa di consumo. Nel 1844, a Rochdale, località nell’hinterland di Manchester, cuore industriale dell’Inghilterra del XIX secolo, un gruppo di 28 addetti al settore tessile creò quella che è considerata la prima cooperativa al mondo. In realtà, anche in precedenza vi erano state numerose esperienze associative o imprenditoriali di carattere cooperativistico, ma quella di Rochdale fu la prima ad avere grande successo e ad innescare un vastissimo processo imitativo [Brown 1944].
La Rochdale equitable pioneers society – in italiano Società dei probi pionieri di Rochdale – era nata per operare nel commercio di generi alimentari di prima necessità e il 21 dicembre 1844 aprì ufficialmente i battenti il suo punto vendita. Si trattava di un modesto locale arredato in maniera spartana che inizialmente vendeva solo burro, zucchero, farina e candele. I soci avevano versato una sterlina a testa, a formare un piccolo capitale di 28 sterline che era servito per avviare l’attività. Nei propositi dei fondatori il negozio avrebbe dovuto fare concorrenza agli spacci gestiti dai negozianti privati che si erano accordati per tenere alti i prezzi. Non solo, ma molti di loro cercavano di incrementare i profitti adulterando le merci vendute, ad esempio allungando la farina con polvere di roccia caolina. Questi comportamenti non solo erano delle truffe a discapito del consumatore, ma spesso provocavano veri e propri danni alla salute.
Di qui l’idea dei 28 Probi Pionieri di associarsi per aprire un proprio emporio, all’insegna della qualità dei prodotti commercializzati e della convenienza in fatto di prezzi. Si trattava della base del moderno cooperativismo, che divenne un modello imitato in altre realtà, prima anglosassoni, poi europee, ed infine extraeuropee, con applicazioni anche in ambiti economici differenti, come l’agricoltura, la manifattura, il credito, i servizi all’impresa e alla persona [Cole 1947].
In Italia la prima cooperativa di consumo aprì i battenti nel 1854, a Torino. Nell’Ottocento la cooperazione italiana produsse numerose esperienze di valore e in età giolittiana ebbe un ulteriore sviluppo, tanto che questo periodo è stato definito «epoca d’oro della cooperazione». Tuttavia, erano soprattutto certe regioni centro-settentrionali a mostrare una vocazione cooperativistica, e tra queste in particolar modo l’Emilia-Romagna, che nel corso del XX secolo si è definitivamente consacrata come culla della cooperazione italiana [Fornasari e Zamagni 1997].
Oggi, a Villanova di Castenaso, località alle porte di Bologna, ha sede la più grande cooperativa di consumo europea, denominata Coop Alleanza 3.0, forte di circa 350 punti vendita, 22.000 dipendenti, 2.700.000 soci e 5 miliardi di euro di fatturato. Inoltre, in un altro paese dell’hinterland di Bologna, Casalecchio di Reno, ha sede il consorzio Coop Italia, titolare del brand Coop ed epicentro del sistema di approvvigionamenti [De Maria e Menzani (eds.) 2015]. Quindi attualmente, Bologna è uno snodo cruciale di un sistema nazionale di cooperative di consumo; di qui l’interesse ad approfondire il caso felsineo.
In particolare, oltre a considerare aspetti quantitativi e qualitativi di questa storia della cooperazione di consumo in provincia di Bologna, introdurremo un’analisi merceologica dei prodotti che venivano venduti sugli scaffali degli spacci e degli empori considerati. Si sono utilizzate fonti documentarie prodotte negli anni tra le due guerre, e principalmente la cosiddetta «letteratura grigia», costituita da rapporti ad uso interno, pubblicazioni delle organizzazioni di rappresentanza, riviste edite dal movimento cooperativo, e simili. Questo genere di materiale ci ha permesso di ricostruire le principali dinamiche economiche e organizzative, viceversa non ha rivelato troppe informazioni sugli articoli commercializzati dalle cooperative, motivo per il quale quest’ultima parte della ricerca risulta più sfumata.
La cooperazione e l’avvento del fascismo
Alla fine della prima guerra mondiale il territorio bolognese fu interessato da problemi di ordine economico e sociale, come una crescente disoccupazione e un preoccupante carovita. Di fronte a questo scenario, da più parti la società civile rispose con forme di auto-organizzazione, per cui il numero di cooperative crebbe esponenzialmente in tutta la provincia. Basti pensare che tra il 1918 e il 1922 vennero fondate 109 cooperative di consumo, che si innestavano su un tessuto preesistente di alcune decine di sodalizi [Gurioli e Romagnoli 1987]. Si può dire che quasi ogni rione cittadino e quasi ogni località della provincia avesse visto sorgere la propria cooperativa di consumo.
Si trattava per lo più di realtà monospaccio, cioè con un unico punto vendita, in cui erano commercializzati generi di prima necessità a favore di soci che abitavano nelle vicinanze. Spesso il numero dei clienti si aggirava attorno ad alcune decine o a qualche centinaio, per cui si trattava di basi sociali modeste, spesso sensibilizzate da qualche esponente locale del socialismo o del cattolicesimo sociale.
Contemporaneamente a livello politico si stava facendo strada il neonato partito fascista. Quest’ultimo ebbe nel movimento cooperativo un proprio obiettivo polemico, a seguito di due questioni principali, una di carattere ideale e una pratica. L’impresa cooperativa era fondata sulla democrazia assembleare esercitata dai soci ed era storicamente collegata a culture politiche di sinistra o progressiste, e comunque antifasciste; in particolare, a Bologna e provincia era molto forte il legame tra cooperative e Partito socialista. Ma, soprattutto, i diretti concorrenti delle cooperative erano gli agrari, i negozianti, i piccoli imprenditori, ossia uno dei corpi sociali che costituivano la base di massa del fascismo. Proprio nel Bolognese, tra i sostenitori di Mussolini vi erano numerosi commercianti ed esercenti che si erano visti erodere sensibilmente i profitti dalle neonate cooperative, la cui concorrenza non aveva tardato a farsi sempre più incisiva [Furlan 1988].
Inizialmente, Mussolini e i suoi attaccarono violentemente la cooperazione, anche quella di consumo, con una campagna di stampa diffamatoria e denigratoria, portata avanti in maniera propagandistica soprattutto su mezzi d’informazione vicini alle destre. Ma poco dopo si passò dalla violenza verbale alla violenza fisica. Lo squadrismo s’indirizzò anche contro gli spacci autogestiti, sui quali si sarebbe anche rapidamente abbattuta quella «mannaia riprivatizzatrice» che in tutta Italia avrebbe falcidiato migliaia di cooperative di consumo [D’Attorre 1988, 100]. In uno di questi attacchi, l’11 gennaio 1925, restò ucciso Augusto Pulega, presidente della «Malcantone» una delle più importanti cooperative di consumo bolognesi, con sede presso il quartiere Barca [Albertazzi, Arbizzani e Onofri (eds.) 1995].
Una volta che il fascismo fu saldamente al potere, la strategia nei confronti della cooperazione venne rapidamente a modificarsi. Le violenze squadriste cessarono, e così pure la propaganda anti-cooperativa. Si ebbe, invece, un approccio più istituzionale, attraverso la progressiva imposizione di uomini vicini al partito fra i dirigenti. Fase cui si accompagnò a una nuova teoria economica della cooperazione, la cui formulazione fu complessa, controversa e, in fin dei conti, fallimentare. L’idea di fondo era di tagliare i ponti con il recente passato e di riscoprire una presunta purezza nella cooperazione delle origini, tradita poi dalle interpretazioni marxiste o cristiano-sociali. Il tutto doveva poi essere declinato in senso nazionalista, a creare una fantomatica «cooperazione fascista», meglio orientata in senso maggiormente interclassista. Dunque il neonato regime non omologò le cooperative alle altre imprese, magari rivedendone la natura giuridica, né decise di chiuderle tutte d’ufficio, bensì legittimò questo modello entro una nuova cornice ideologica [Degl’Innocenti 1995].
Di fatto, in provincia di Bologna, molte cooperative nate nel primo dopoguerra erano cessate indipendentemente dal fascismo, perché fragili da un punto di vista organizzativo o perché avevano ubbidito ad un bisogno immediato, di contrasto al carovita, dopodiché erano state liquidate. Alcune, altre, invece, avevano chiuso i battenti a seguito di vandalismi provocati dagli squadristi, o di semplici intimidazioni rivolte ai gestori o ai soci. Stando alle ricostruzioni statistiche più attendibili, e traendo da queste alcune stime, in tutta la provincia felsinea alcune decine di cooperative di consumo furono indotte a sciogliersi con metodi violenti [Franceschelli 1949].
In alcuni casi più rari, poi, il fascismo aveva imposto delle fusioni coatte. Dal momento che in certe località più grandi si facevano concorrenza due o tre sodalizi distinti, che si richiamavano a culture politiche differenti, si scelse di procedere ad una serie di accorpamenti. Poiché la nuova dottrina cooperativa era presentata come apolitica, appariva certamente irrazionale ed inutile che in uno stesso paese convivessero più cooperative di consumo. Queste divisioni, maturate a partire da interpretazioni diverse dell’associazionismo cooperativo e dei suoi scopi, dovevano essere cancellate, e i singoli sodalizi di uno stesso comparto e di uno stesso comune dovevano essere indotti a fondersi. In questa prospettiva – che pure conteneva indubbiamente alcuni elementi di modernità e di razionalità – si condensavano le contraddizioni di un pensiero cooperativo fascista che tentava di coniugare autogestione ed autoritarismo [Menzani 2009].
Con una serie di richieste, pressioni e minacce, si forzarono questi accorpamenti, che quasi sempre portavano alla decapitazione del gruppo dirigente meno accondiscendente ed alla sostanziale conferma di quei consiglieri e tecnici che non si erano opposti all’unificazione. In quasi tutti i casi la fusione fu imposta dall’alto e condotta all’insegna di un generale disinteresse dell’opinione dei soci, per lo più persuasi ad assecondare il volere dei gerarchi fascisti.
«La preoccupazione – si scriveva nel 1933 sulla rivista “Vita cooperativa” – non è quella di ridurre il numero delle cooperative, ma di fare, ove è possibile, di più organizzazioni deboli e di scarsa efficienza una sola più forte e meglio impostata tecnicamente e finanziariamente» [1].
In alcune province poi, come quella di Bologna, questa ristrutturazione interessò quegli istituti di natura pubblica che erano sorti nel corso del conflitto o nel primo dopoguerra per alleviare le difficoltà di approvvigionamento alimentare della popolazione. Nel caso felsineo, il sindaco socialista Francesco Zanardi aveva creato, nel 1914, l’Ente autonomo dei consumi. Nel 1920, prima ancora che il fascismo conquistasse il potere cittadino, tale Ente assorbì la Cooperativa di consumo di Bologna, che era nata nel 1911 e scontava alcuni problemi di gestione. Tuttavia, nel 1933 l’Ente fu prima commissariato dal fascismo e poi definitivamente liquidato due anni dopo. Contestualmente risorgeva la Cooperativa di consumo di Bologna, che avrebbe operato sul finire degli anni Trenta e per tutta la fase della seconda guerra mondiale e del successivo dopoguerra, prima di intrecciare nuovamente la propria strada con l’Ente autonomo dei consumi, rifondato nel 1947 [Baravelli 2008].
Le ragioni che portarono – a Bologna come in altre località italiane – a questa commistione fra cooperative di consumo ed enti di consumo di emanazione comunale (o comunque pubblica) si deve essenzialmente a problemi di governance delle prime, così come scritto da Rosario Labadessa in un testo destinato a diventare una pietra miliare degli studi sul movimento:
«Purtroppo il novanta per cento dei soci delle cooperative di consumo ignora i principi, le finalità, lo stato attuale, la vita, gli sforzi, ed i bisogni della sua organizzazione. […] Le cooperative di consumo sono affidate ai loro dirigenti, i quali, se non vogliono essere oggetto di derisione e di deplorazione, devono sagrificare [sic] tutto e cavarsela da soli nella direzione di quest’azienda che è infinitamente più difficile a guidarsi che non quella privata. I dirigenti delle cooperative di consumo non hanno mai ribassato abbastanza i prezzi, ma guai a loro se l’azienda va in fallimento. Essi devono ridurre a zero le spese generali, ma guai a loro se non mettono a posto qualche incapace fannullone molto influente, e così via… Qualche volta questi dirigenti sono disonesti, e allora chi li caccia e li punisce? Raramente gli organi sociali del movimento hanno abbastanza sensibilità per accorgersi in tempo di essersi affidati male» [Labadessa 1930, 128-129].
Di qui, sempre secondo Labadessa, la necessità di un intervento pubblico a livello locale, là dove la cooperazione di consumo mostrava di non funzionare correttamente:
«Questo male della cooperazione, universalmente avvertito, se anche non sufficientemente discusso in Italia, ha spinto coloro che miravano a svolgere una efficace azione di difesa dei consumatori a cercare forme diverse da quella tradizionale cooperativa; sono sorte così le aziende annonarie e gli enti autonomi dei consumi, aziende municipali ed aziende miste, con partecipazione quest’ultime di enti pubblici e di singoli consumatori; alcune cooperative hanno sentito il bisogno di evolversi in questo stesso senso cercando di sostituire ai soci consumatori, sempre assenti, istituti od organizzazioni che rappresentassero largamente gli interessi dei consumatori [Labadessa 1930, 131]»
Negli anni del fascismo, questo interessante dibattito fra i favorevoli ad un’autogestione dal basso (le cooperative) e i fautori di un dirigismo dall’alto (l’ente pubblico) non suscitò troppo interesse, perché la fascistizzazione e il controllo delle principali cooperative di consumo – di cui tratteremo a breve – le aveva in buona parte accomunate a pezzi della pubblica amministrazione, per cui veniva meno il distinguo suaccennato.
A prescindere da questa vicenda specifica, alla vigilia della crisi del 1929, in tutta la provincia di Bologna erano rimaste 30 cooperative di consumo [2]. Si trattava di sodalizi un poco più strutturati rispetto alla pletora di piccole o piccolissime realtà del primo dopoguerra, ma era certamente una selezione che aveva il sapore di un arretramento. Nel corso degli anni Trenta, a queste cooperative si aggiungevano alcuni spacci aziendali autogestiti attraverso l’Opera nazionale dopolavoro (Ond), che dal punto di vista giuridico risultavano essere cooperative di consumo [Gurioli e Romagnoli 1987; Vigilante 2014].
Le attività delle cooperative di consumo fra le due guerre
Cerchiamo ora di capire come queste cooperative furono trasformate dal regime. Nel 1923 il prefetto di Torino esautorava l’Associazione generale operaia e affidava la storica Alleanza cooperativa torinese ad una gestione commissariale. Con la «conquista» della prima cooperativa italiana, il fascismo si preparava idealmente a passare dalla fase di lotta a quella di gestione.
L’opera di revisione fu impostata attorno alla creazione di tre diverse tipologie di cooperativa di consumo, da applicare in funzione dei contesti e delle necessità. La prima era quella costituita in società per azioni, sulla base degli articoli 219 e 228 del codice di commercio, che era aperta al pubblico e che rilasciava all’acquirente una polizza di quietanza da far valere nella divisione degli eventuali utili, dopo il riparto del ristorno assegnato ai soci, e che si richiamava apertamente all’Unione cooperativa di Milano, fondata nel 1886 da Luigi Buffoli e Francesco Viganò. La seconda tipologia si ispirava al modello delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, il cui statuto, sia pure con notevoli modifiche, originava dalla legge austriaca del 9 aprile 1873 sui consorzi industriali ed economici. Esso imponeva un più stretto rispetto della mutualità e prevedeva che la quota nominale iscritta nel registro dei soci fosse improduttiva di dividendo, il quale, invece, veniva corrisposto proporzionalmente al momento dell’acquisto, sul modello del ristorno. Il terzo tipo era quello degli istituti o enti autonomi, affini alle cooperative, che erano sotto il patronato totale o parziale di enti pubblici, e che si richiamavano alle analoghe esperienze maturate durante la Grande guerra, in momenti contingenti [Degl’Innocenti 1981].
Nel caso di Bologna, come già evidenziato l’ente voluto da Zanardi ebbe una storia intrecciata con la principale cooperativa di consumo felsinea.
Tuttavia, in generale, il modello preferito fu il secondo, perché l’associazione cooperativa assomigliava a una sorta di grande famiglia, e perché gli acquisti e le distribuzioni erano più strettamente collegati alle pratiche assistenziali. Alle cooperative di consumo, infatti, veniva agganciato l’intento morale del mutuo soccorso, dell’educazione, dell’igiene, ma pure della propaganda, attraverso varie iniziative, come ad esempio le colonie marine e montane per i figli dei soci. In teoria, inoltre, all’impresa di consumo si sarebbe dovuto collegare l’esercizio di una cassa sociale per raccogliere i depositi vincolati dei soci, così come teorizzato e suggerito da Leone Bolaffio, giurista che godeva di una certa stima negli ambienti cooperativi fascisti. In realtà, però, la realizzazione pratica di questo ulteriore intervento previdenziale fu piuttosto insoddisfacente, e la cooperativa di consumo fascista rimase un ibrido incompiuto, a metà fra impresa commerciale ed ente mutualistico, privo di un’adeguata tutela legislativa che ne valorizzasse la competitività e l’efficienza. Veniva così mitigato quel ruolo di calmierazione dei prezzi al consumo, che le cooperative ed i loro consorzi avevano saputo svolgere in età prefascista, a tutela dei soci e dei clienti in genere, che si voleva macchinosamente sostituire con l’istituzione di alcune forme mutualistiche, di portata – e soprattutto di significato – ben differente.
Il processo di ristrutturazione del settore fu portato avanti attraverso numerosi altri provvedimenti, il più importante dei quali fu l’istituzione dell’Ente centrale approvvigionamenti (Eca, e dal 1938 Eica), che possiamo considerare l’antenato del consorzio nazionale per gli acquisti collettivi e cioè l’Ancc (poi Coop Italia), se ci riferiamo al movimento imperniato sulla Lega, che nel lungo periodo fu quello che ottenne i risultati più brillanti in fatto di consumo e che avrebbe avuto Bologna come epicentro [Zamagni, Battilani e Casali 2004]. La costituzione di questo ente, avvenuta nel 1927, era un provvedimento sicuramente utile per la modernizzazione della cooperazione di consumo italiano.
Pur con tutti i suoi limiti, fra i quali il raggio d’azione ancora limitato, l’Eca rappresentava quell’agenzia unica di acquisto, alla quale i cooperatori avevano ambito fin dall’Ottocento, quando in molti avevano iniziato a guardare con ammirazione all’inglese Co-operative wholesale society (Cws). Tuttavia, mentre nella dottrina cooperativa questo consorzio delle cooperative di consumo doveva scaturire dal basso, ossia dalla comunione degli sforzi dei singoli sodalizi, nel caso italiano, l’Eca era il prodotto di un’operazione di salvataggio e normalizzazione, dopo il disordine degli anni precedenti, che proveniva dall’alto e trovava forti corrispondenze nella politica monetaria di stabilizzazione della lira, senza ubbidire ad alcuna necessità di democratizzazione nel settore distributivo [Degl’Innocenti 1986, 125].
Per queste ragioni, la storiografia ha per lungo tempo trascurato il ruolo di questo ente – salvo riconoscerne recentemente l’imprescindibile ruolo economico –, anche per via di un giudizio complessivamente negativo sull’operato del regime in fatto di consumi. Pur se il numero delle cooperative effettivamente agganciate all’Eca risultò sempre piuttosto basso, si deve sottolineare come, in pochi anni di attività, questo ente avesse raggiunto rapidamente i 100 milioni di lire di vendite, incidendo favorevolmente sulla riattivazione dei circuiti economici e solidaristici del movimento del consumo [Casali 1994]. Piuttosto, bisogna convenire che la mancata evoluzione dell’Eca, in termini di efficienza aziendale e di ampliamento del proprio giro d’affari, si ripercosse in maniera negativa sul movimento del consumo, che continuava a scontare una forte polverizzazione e una base sociale poco numerosa.
Spaccato tra volontà modernizzatrici e tutele corporative, il fascismo era stato sostanzialmente incapace di dare unità di azione alle proprie politiche relative alla cooperazione di consumo. Da una parte si predicavano le scelte aziendalistiche e dall’altra non si volevano turbare gli esercenti privati promuovendo cooperative di consumo davvero competitive.
L’unica eccezione, appunto, era la costituzione dell’Eca, che, però, tradiva la cultura dell’autogestione e si profilava come un ente calato dall’alto, quasi un regalo che il Duce aveva voluto fare ai cooperatori, come nella tradizione autoritaria e paternalistica del nuovo regime. In tutta l’Emilia-Romagna erano 90 le cooperative che usufruivano dei servizi di questo consorzio nazionale, per un totale di 227 punti vendita e 17.000 soci, e nel 1937 si erano approvvigionate dall’Eca per un valore di poco inferiore ai 60 milioni di lire. Non abbiamo dati specifici per la provincia di Bologna, ma in ogni caso – in base al dato regionale – possiamo convenire sul fatto che si trattava di cifre abbastanza basse [3].
Le cooperative di consumo: com’erano?
Resta ora da capire come le cooperative di consumo bolognesi si presentassero alla propria clientela nel periodo fra le due guerre. Purtroppo le fonti consultate sono avare d’informazioni più strettamente merceologiche e ci consentono di ricavare solo alcuni dati parziali e frammentari. La stessa storiografia sulla cooperazione si è scarsamente interessata di questi aspetti, salvo qualche riferimento un poco più ampio (Casali 1997; Casadio 2009). Innanzitutto, occorre contestualizzare il fenomeno in un panorama in cui il commercio al dettaglio italiano appariva quanto mai arretrato rispetto agli altri paesi europei, dove era generalmente già comparsa la grande distribuzione imperniata sui moderni supermercati [Zamagni 1985].
Bisogna anche distinguere fra le piccole cooperative monospaccio del primo dopoguerra, in genere con un bacino d’utenza molto ridotto, e le poche realtà più grandi che emersero progressivamente tra la fine degli anni Venti e il decennio successivo.
Le piccole cooperative figlie dei problemi successivi alla Grande guerra erano collocate per lo più in negozi modesti, talvolta angusti e affollati soprattutto di generi di prima necessità che si vendevano sfusi. I prodotti più commercializzati erano «la farina, lo zucchero, i legumi, i salumi, il burro, le uova, il vino e poco altro» [4]. Molto spesso erano trattati anche «articoli non alimentari, come il sapone, le candele, le stoffe» [5]. Tutta la merce era servita ai clienti da un commesso, che in certi casi poteva essere coadiuvato da altri addetti. Questi ultimi si occupavano per lo più per esigenze logistiche di rifornimento della bottega, e solo saltuariamente interagivano direttamente con i clienti.
Oltre alle cooperative di consumo vere e proprie, ve ne erano alcune altre che potremmo definire «miste», perché la loro attività era in sinergia con un’altra area di business. Alcune sembravano vicine al modello della casa del popolo o del circolo ricreativo (in particolare in campagna), per cui vendevano prodotti – in particolare vino – che i clienti potevano consumare direttamente sul posto, tra una chiacchiera e una partita a carte. Altre, invece, erano l’output commerciale di una cooperativa agricola, e dunque rivendevano direttamente al dettaglio una parte di ciò che era coltivato dai soci, contadini o braccianti che fossero.
Le cooperative più grandi, invece, erano un poco più strutturate. In molte di esse, la superficie di vendita consentiva un assortimento maggiore, per cui non era raro che avessero un reparto macelleria e che commercializzassero molti più prodotti confezionati, in parte provenienti dal consorzio nazionale Eca. Tra questi «la cioccolata, le caramelle, la birra e i liquori» [6]. Tra l’altro, in questi empori si trovava spesso un angolo bar, per la mescita di vino e la somministrazione di altre bevande, che fungeva anche da luogo di ritrovo e di socializzazione tra gli iscritti della cooperativa di consumo. Spesso era soprattutto la classe media di tendenze politiche progressiste e antifasciste a frequentare questi luoghi, e il regime tollerava tale situazione perché consapevole del fatto che in questa maniera avrebbe potuto meglio controllare gli oppositori [Menzani 2014].
Soprattutto nelle aree di campagna, le cooperative esercitavano il cosiddetto credito di banco, ossia vendevano i prodotti ai soci – contadini, mezzadri o braccianti che fossero – e incassavano solamente quando i proventi dell’annata agraria o il pagamento dei salari consentivano ai clienti di saldare le spettanze. Alla lunga però, questa prassi portò molte cooperative a indebitarsi e a soffrire di problemi di liquidità, dato che non sempre era possibile scaricare questo ritardo nei pagamenti sui fornitori, che in genere erano grossisti locali [Labadessa 1933]. Questo problema sarebbe stato risolto solamente negli anni del miracolo economico [Battilani 1999].
La scarsità di fonti non ci consente di conoscere informazioni che sarebbero rilevanti, come ad esempio il rapporto tra i prezzi dei prodotti delle cooperative e quello praticato dagli altri esercenti limitrofi. Così come non ci è dato sapere se la qualità delle merci fosse molto difforme dagli standard o se il layout dei punti vendita fosse davvero molto meno curato rispetto agli allestimenti dei commercianti privati. In genere, la vulgata ci ha portato a ritenere che nelle cooperative di consumo il rapporto qualità/prezzo fosse migliore, ma anche che vi fosse una prevalenza di merci popolari, con minore spazio per i prodotti destinati ai ceti medio-alti, il tutto all’interno di negozi semplici, spartani e un poco trascurati. Tuttavia, ad oggi, le informazioni a conforto di questa interpretazione sono effettivamente ridotte, ma ci consentono di cogliere come le cooperative di consumo si “sproletarizzarono” nel corso degli anni Trenta, acquisendo anche una clientela piccolo e medio borghese.
Conclusioni: effetti ed eredità
Su base nazionale, l’impatto dell’ideologia e del governo fascista sulla cooperazione di consumo è da considerare in termini generalmente negativi, pur se con alcune significative eccezioni, legate a singoli aspetti di carattere organizzativo e commerciale. Agli albori degli anni Venti la cooperazione di consumo bolognese si presentava come fortemente parcellizzata e tuttavia, abbastanza promettente. Gli stessi cooperatori erano consci della necessità di ristrutturare questa pletora di piccole e vivaci realtà, con un’opera di razionalizzazione e con l’attivazione di sinergie per la centralizzazione degli acquisti. È anche verosimile credere che una parte del movimento presagisse che, di lì a poco, più che una razionalizzazione basata su fusioni o strategie consortili sarebbe stata una selezione operata dalla competizione nel mercato a mettere ordine in questo magmatico mondo. E quindi, varie cooperative nate sull’onda delle necessità postbelliche, con una buona dose d’improvvisazione, avrebbero presto chiuso i battenti.
Ma quasi nessuno avrebbe profetizzato un netto ripiegamento della cooperazione di consumo felsinea su se stessa, dovuto non solo all’andamento del mercato e alla logica della concorrenza, bensì in buona parte imputabile all’avvento del fascismo. Negli anni dello squadrismo si ebbe una chiara inversione di rotta in questo trend di sviluppo, tanto che si può sostenere che il settore del consumo cooperativo fu tra i più colpiti e penalizzati dal nuovo regime. Alcuni dati nazionali sono molto eloquenti. Nel 1938, il 95,3% della distribuzione italiana era gestita da esercenti tradizionali o da ambulanti, contro il 66% della Gran Bretagna; l’incidenza della cooperazione di consumo in questi due paesi era rispettivamente del 3,1% e del 10%, mentre quello della grande distribuzione dello 0,8% e del 19%, a testimonianza dell’arretratezza italiana in questo settore [Zamagni 1981, 22-23].
Sul piano operativo gli anni fra le due guerre non furono così negativi. La cooperazione di consumo subì un impoverimento oggettivo, nonché un utilizzo clientelare di certe compagini governate da uomini in camicia nera, ma nel contempo si veicolò la rete di vendita verso una modernizzazione. Nel primo dopoguerra, gli spacci cooperativi avevano un layout dimesso e si rivolgevano prevalentemente ai ceti popolari, mentre negli anni del fascismo accentuarono una dimensione commerciale e interclassista. Ciò sarebbe risultato importante nel secondo Novecento, quando la società del benessere produsse un infoltimento della middle class che mise in crisi e portò al fallimento molte cooperative di consumo europee, ma non quelle italiane che già nel corso degli anni Trenta avevano intercettato i consumi dei ceti medi.
Lungo questi controversi percorsi, gli spacci cooperativi bolognesi attraversarono il ventennio e la seconda guerra mondiale e, all’indomani della Liberazione, poterono portare un’eredità – di aziende, di beni, di persone, di competenze – alla neonata cooperazione democratica. In questo, il periodo intrabellico è giocoforza da considerare una fase di ombre e luci per la cooperazione di consumo felsinea.
Bibliografia
- Albertazzi A., Arbizzani L. e Onofri N.S. (eds.) 1995
- Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel Bolognese, 1919-1945, Bologna: Comune di Bologna e Istituto per la storia di Bologna.
- Baravelli A. 2008
- Il giusto prezzo. Storia della cooperazione di consumo in area adriatica, 1861-1974, Bologna: Il Mulino.
- Battilani P. 1999
- La creazione di un moderno sistema di imprese. Il ruolo dei consorzi della cooperazione di consumo dell’Emilia Romagna, Bologna: Il Mulino.
- Brown W.H. 1944
- The Rochdale Pioneers: a Century of Co-operation in Rochdale. A Centenary Record of the Rochdale Equitable Pioneers Society, Rochdale: Rochdale Equitable Pioneers Society.
- Casadio A. 2009
- L’età delle illusioni. La cooperazione di consumo dalla prima guerra mondiale al fascismo, in Baravelli A. 2009, Un secolo di cooperazione di consumo a Ravenna (1981-1980), Ravenna: Longo.
- Casali A. 1994
- I consorzi cooperativi nella cooperazione di consumo italiana. Dall’Ufficio centrale di provvedimento di Vercelli alla Coop Italia, 1887-1993, Firenze: Consorzio cooperative di consumo
- Casali A. 1997
- Storia della cooperazione di consumo pisana. Dalla Società Cooperativa di Consumo per il Popolo alle Cooperative Pisane Riunite, Pisa: Unicoop.
- Cole G.D.H. 1947
- The Rochdale Principles. Their History and Application, London: London Co-operative Society.
- D’Attorre P.P. 1988
- I tempi lunghi della modernizzazione, in D’Attorre P.P., Errani P.L. e Morigi P. (eds.) 1988, La città del silenzio. Ravenna tra democrazia e fascismo, Milano: Franco Angeli.
- De Maria C. e Menzani T. (eds.) 2015
- Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione a oggi, Bologna: Bradypus.
- Degl’Innocenti M. 1981
- Geografie e strutture della cooperazione in Italia, in Sapelli G. (ed.) 1981, Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi, Torino: Einaudi.
- Degl’Innocenti M. 1986
- L’impresa cooperativa in Italia nella lotta per l’occupazione e nella difesa del consumatore, in Degl’Innocenti M. (ed.) 1986, Le imprese cooperative in Europa dalla fine dell’800 alla seconda guerra mondiale, Pisa: Nistri-Lischi.
- Degl’Innocenti M. 1995
- La società unificata. Associazione, sindacato, partito sotto il fascismo, Manduria-Bari-Roma: Lacaita.
- Fornasari M. e Zamagni V. 1997
- Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992), Firenze: Vallecchi
- Franceschelli M. 1949
- L’assalto del fascismo alla cooperazione italiana, 1921-1922, Roma: Editrice Coop.
- Furlan P. 1988
- La cooperazione di consumo bolognese nel fascismo, in Degl’Innocenti M., Pombeni P. e Roveri A. (eds.) 1988, Il PNF in Emilia Romagna. Personale politico, quadri sindacali, cooperazione, Milano: Franco Angeli.
- Gurioli A. e Romagnoli E. (eds.) 1987
- Repertorio delle cooperative di Bologna e Provincia (1883-1987), Bologna: Federcoop.
- Labadessa R. 1930
- Cooperative di consumo e consumatori, Roma: La Formica
- Labadessa R. 1933
- Il bilancio della cooperazione di consumo in Italia, «Rivista di Politica economica», 3.
- Menzani T. 2009
- Il movimento cooperativo fra le due guerre. Il caso italiano nel contesto europeo, Roma: Carocci.
- Menzani T. 2014
- Welfare locale e cooperazione in Emilia-Romagna tra le due guerre, in Betti E. e Salfi A. (eds.) 2014, Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare state, Roma: Ediesse.
- Vigilante E. 2014
- Opera nazionale dopolavoro: tempo libero dei lavoratori, assistenza e regime fascista, 1925-1943, Bologna: Il Mulino.
- Zamagni S. e Zamagni V. 2010
- Cooperative Enterprise. Facing the Challenge of Globalization, Cheltenham-Northamton: Edward Elgar.
- Zamagni V. 1981
- La distribuzione commerciale in Italia fra le due guerre, Milano: Franco Angeli.
- Zamagni V. 1985
- Dinamica e problemi della distribuzione commerciale al minuto tra il 1880 e la IIª guerra mondiale, «Commercio», 20.
- Zamagni V., Battilani P. e Casali A. 2004
- La cooperazione di consumo in Italia. Centocinquant’anni della Coop consumatori: dal primo spaccio a leader della moderna distribuzione, Bologna: Il Mulino.
Note
1. Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale (d’ora in poi CIDC), fondo Cooperazione fascista, Bollettino dell’Ente nazionale fascista della cooperazione “Vita cooperativa”, 4, novembre 1933, pp. 103-114 (Concentramento delle cooperative di consumo esistenti nello stesso comune).
2. Archivio della Camera di commercio di Bologna, volume statistico Provincia anno X (La cooperazione in provincia di Bologna, 1649-1659).
3. CIDC, fondo Cooperazione fascista, Ente nazionale fascista della cooperazione 1938, Le cooperative inquadrate nell’Ente nazionale fascista della cooperazione. Riepilogo statistico generale, Roma: Enfc.
4. CIDC, fondo Cooperazione fascista, Bollettino dell’Ente nazionale fascista della cooperazione “Vita cooperativa”, 3, luglio 1936, pp. 34-36 (Andamenti delle vendite con confronti fra le province
5. Ibidem.
6. CIDC, fondo Cooperazione fascista, Bollettino dell’Ente nazionale fascista della cooperazione “Vita cooperativa”, 3, luglio 1936, pp. 37-38 (La Bolognese: una cooperativa di consumo