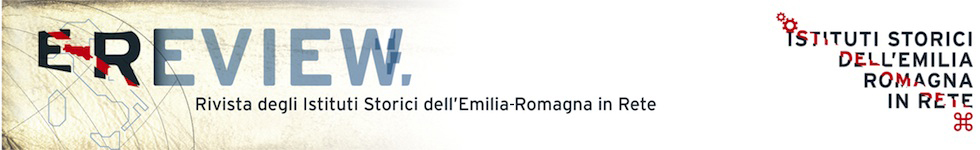Il progetto “Esposizione permanente relativa alla storia d’Italia nel Ventennio fascista” da allestire nell’ex Casa del fascio e dell’ospitalità di Predappio è stato elaborato da un Comitato scientifico che fa capo all’Istituto Parri di Bologna ed è stato fortemente voluto dal sindaco e dal governo allora guidato da Matteo Renzi. Il progetto è stato finanziato con un milione di euro dalla Regione Emilia Romagna, 500 mila euro elargiti rispettivamente dal Comune e dalla Cassa di Risparmio, mentre il governo a suo tempo ha promesso 2 milioni di euro.
I punti di riferimento per capire di cosa si tratta sono due documenti: il primo, con le “linee guida”, risale al 2015; il secondo, il progetto definitivo della mostra, è del 2017. Pur con qualche significativa differenza, entrambi presentano un intreccio inestricabile tra le ragioni dell’uso pubblico della storia e quelle del dibattito storiografico vero e proprio.
Nelle “linee guida”, si indica come obbiettivo la «trasmissione della conoscenza storica», accennando a un allestimento con «nuove tecnologie» per «creare emozioni». Nel complesso vi si respira un’aria di marcata “neutralità” («un museo storico non è mai, se concepito o realizzato con criteri moderni, una celebrazione di “un punto di vista” della storia, né di quello che ha vinto, ma neppure di quello più “giusto”, bensì lo strumento per comprendere la storia e interagire con essa sulla base della conoscenza, dei valori, dei problemi del presente»), con la rinuncia a qualsiasi “punto di vista”, a quello “dei vincitori “, ma anche a quello “più giusto”. Nel tentativo di rassicurare una comunità degli storici, evidentemente perplessa, era stato allora presentato un manifesto di solidarietà con i promotori che però, senza entrare nel merito storiografico del progetto, si era limitato ad apprezzare «le garanzie di serietà, di rigore scientifico, capacità narrativa, ricchezza documentaria e capacità divulgativa e didattica che il sindaco Frassineti ha sempre posto come requisiti necessari perché l’iniziativa possa prendere corpo», prendendo atto delle «buone intenzioni» del sindaco (del Partito democratico) di Predappio e dello stesso governo («che un governo decida di intervenire in aiuto di una simile iniziativa [...] è sembrato un segnale positivo»).
Ad accentuarne gli aspetti più tipicamente legati all’uso pubblico della storia rispetto a quelli presenti nel dibattito storiografico era poi intervenuto Marcello Flores, uno dei membri più autorevoli del Comitato scientifico: «chi conosce Predappio”- aveva scritto su “Doppiozero”- sa che la realtà odierna è molto diversa da quella di 20 o 40 anni fa e che gran parte dei nostalgici che vi si recano, non sono più i picchiatori fanatici di un tempo [...] ma spesso figli o nipoti di ex fascisti che guardano con curiosità e spesso disincanto a quel luogo dove potrebbero trovare anche informazione storica ed educazione alla critica invece che solo la cripta del Duce». La ostentata rinuncia a “un punto di vista” interpretativo si rivelava così perfettamente congruente con l’ipotesi politico-culturale sulla quale si reggeva il progetto: in un paese “normalizzato”, la contrapposizione fascismo/antifascismo si è molto diluita; nessun pericolo neofascista si segnala all’orizzonte, una memoria pacificata e condivisa si confronta serenamente con alcuni residui “nostalgici“, destinati a essere superati in un bisogno di conoscenza storica che cancella le antiche passioni ideologiche di un Novecento ormai definitivamente superato. Per essere più esplicito Flores aggiungeva: «pensare che, più di 70 anni dopo la caduta del fascismo, il suo revival - anche soltanto culturale e storiografico - sia ancora una minaccia, equivale a ignorare i cambiamenti avvenuti nel modo in cui parliamo del passato, non solo nella società italiana, ma in tutta Europa e nel mondo».
Se, nel 2015, su questo giudizio squisitamente politico gravava l’incognita di una verifica elettorale che presto avrebbe smentito i suoi stessi presupposti, nel merito storiografico dell’iniziativa l’assenza di un “punto di vista” lasciava, allora come oggi, come un senso di disorientamento e di disagio. Che operazione sarebbe stata? E una mostra, soprattutto se “moderna” e pronta a intrecciare i linguaggi più diversi, può risultare efficace senza un’ipotesi di fondo che leghi in un percorso coerente i segmenti delle varie narrazioni, le “scene” in cui si articola la rappresentazione museale? Un progetto che punti a emozionare e coinvolgere i visitatori attraverso la spettacolarizzazione e la messa in scena richiede, in realtà, una solida regia centrale, che funzioni non solo dal punto di vista teatrale; a rendere compatta un’esposizione che vive di accensioni e di frammenti emotivi occorre un’ipotesi storiografica di base esplicita, riconoscibile, in grado di guidare e orientare il percorso conoscitivo proposto dall’allestimento, evitando di far precipitare la varietà dei linguaggi in una sorta di babele incomprensibile.
Su queste questioni è successivamente intervenuto il progetto vero e proprio, presentato alla stampa nell’ottobre 2017. Nel documento, alle ragioni dell’uso pubblico della storia si riconosceva ancora una netta supremazia. In questo senso si indicavano due “nemici” da combattere: da un lato «la convinzione diffusa secondo la quale solo la damnatio memoriae verso un regime fondato sulla violenza politica e razziale [...] possa non solo risarcire le vittime, ma prosciugare l’acqua nella quale potrebbe risorgere»; dall’altro la «memoria vigile e armata contro i rigurgiti del fascismo» che «ha finito inevitabilmente per favorire l’oblio, basato su equivoci e luoghi comuni, e alimentare la nostalgia di minoranze fanatiche e ideologizzate». Nel confermare quindi un giudizio complessivamente rassicurante sull’attuale fase politica («viviamo in una società democratica stabile che ha la forza di confrontarsi liberamente e consapevolmente con il suo passato, ancorché tragico, non solo per sapere da dove veniamo, ma anche per produrre anticorpi culturali necessari ad impedire che quel passato, seppur in forme nuove, si ripeta») si consegnava il fascismo alla storia («si è concluso e come tale non può più tornare») e ci si proponeva esplicitamente «di consentire a quel passato di passare attraverso l’elaborazione di un giudizio storico condiviso e maturo». Non più quindi la rinuncia a “un punto di vista” ma l’affidamento a un “giudizio” che con la sua fondatezza “scientifica” fosse in grado di garantire che l’operazione “di far passare il passato” andasse felicemente in porto.
Spostando l’attenzione sul piano storiografico, il documento si caratterizzava per una duplice negazione, rifiutando sia il «paradigma antifascista» («fortemente debitore del quadro interpretativo elaborato dai militanti antifascisti durante gli anni feroci della repressione e nell’esilio, che già dagli anni Settanta aveva cominciato a mostrare tutti i suoi limiti e tutte le sue aporie concettuali»), sia il «revisionismo defeliciano» («che dopo notevoli spinte innovative sul piano scientifico, si è venuto perdendo nei meandri di una presunta storiografia “afascista” e nello sforzo di ridurre il fascismo a “mussolinismo”, a una dittatura personale che copriva un debole e bonario “stato di polizia”, del tutto diverso dal nazismo»). A queste due negazioni si accompagnava “un giudizio” che sembrava però riproporre ancora la rinuncia a un “punto di vista” del primo documento. Il fascismo veniva infatti raccontato attraverso una serie di temi che rinviavano tutti al contesto novecentesco della sua esperienza: la politica di massa, il nesso tra guerra e rivoluzione, la dimensione europea, gli aspetti totalitari, l’impatto con la modernizzazione, il ruolo dell’ideologia, le forme di organizzazione politica (la leadership carismatica, il partito unico), i rapporti con la società... E su questi temi si articolava un progetto espositivo che nella successione dei capitoli sembrava alludere ai modelli manualistici del racconto storico: gli argomenti erano posti in successione uno dopo l’altro, sottolineando l’esigenza di una completezza contenutistica con un approccio rigorosamente cronologico, che partiva dalla prima guerra mondiale e si concludeva con la tragica vicenda di Salò: in mezzo c’era tutto, le leggi razziali e il cinema dei telefoni bianchi, le bonifiche e il mancato giuramento dei dodici professori universitari, l’avvento della radio e la conquista dell’Etiopia..., senza un’impennata, con gli eventi giustapposti uno all’altro, segmenti staccati che riproponevano la piatta esposizione cronologica delle “cronache” medievali, incapaci - in questo - di dare spessore al “giudizio storico” invocato dal progetto.
In realtà, proprio per tener fede alle ragioni dell’uso pubblico della storia così evidentemente evocate dall’iniziativa, ci sono delle domande che anche in sede storiografica non si possono eludere: si può vivere venti anni senza la libertà? Cosa ha rappresentato il fascismo nel progetto di “fare gli italiani” che ci accompagna dagli esordi della nostra storia unitaria? La Repubblica sociale fu solo l’epilogo del Ventennio o ne fu il anche momento del disvelamento più marcato e nitido? Quanto alla “modernizzazione”, quali elementi sono specifici del fascismo italiano e quali appartengono invece al mondo della “grande trasformazione” studiato da Polanyi? Nel cinema, nella radio, nei mezzi di comunicazione di massa, come si distinguono gli aspetti propagandistici tipici del regime da quelli che ci aiutano decifrare la realtà dell’Italia di allora?
Sono domande che per avere risposte hanno bisogno proprio di un “punto di vista”. Non si ritiene di utilizzare quelli del vecchio antifascismo. Ma davvero il fascismo-parentesi di Croce o il fascismo-reazione di classe dei socialcomunisti possono essere accomunati in un unico giudizio liquidatorio con “l’autobiografia della nazione” di matrice gobettiana e azionista?
È certamente vero: la portata storiografica di queste posizioni è stata fortemente ridimensionata da una nuova stagione di studi e di ricerche e oggi anche l’“autobiografia della nazione” appare sempre meno convincente sul piano interpretativo; pure, proprio perchè nel progetto della mostra le ragioni dell’uso pubblico della storia sembrano prevalere su quelle della ricerca e del dibattito tra gli storici, forse – alla luce degli ultimi sviluppi politici segnati dall’egemonia della Lega di Matteo Salvini - nella vecchia formula gobettiana si annidano risorse conoscitive che non è possibile trascurare e che inducono a una riflessione più meditata proprio sul contesto anche geografico in cui si colloca l’iniziativa.
Predappio è un “luogo” inventato dal fascismo prima e dal neofascismo dopo. Lo è nella sua architettura, nel circuito turistico-nostalgico che lega la visita alla casa natale di Mussolini alla cripta in cui è sepolto, nella disseminazione di negozi di souvenir e di vetrine inneggianti a Mussolini che segna le sue strade. Il Duce “costruì” dal nulla la cittadina per testimoniare la propria grandezza, per celebrarvi un “culto” che per venti anni avrebbe caratterizzato tutti gli aspetti rituali e simbolici della nostra religione civile. Poi, nel tempo, pur continuando a essere un’estensione del corpo del Duce, Predappio è diventata un luogo di memoria in cui si raggrumano le istanze più esplicitamente vendicative e rivendicative dei neofascisti: già nel 1983, in occasione del centenario della nascita di Mussolini - in una congiuntura culturale profondamente mutata e politicamente segnata dal dialogo con il Msi di Almirante avviato da Craxi - con la diffusione dei pellegrinaggi organizzati ci fu una prima svolta memoriale seguita, nel 1997, dall’ordinanza del Comune che permetteva l’apertura di negozi di souvenir; nel 1999, infine, fu resa accessibile ai visitatori anche la casa natale del Duce. Da allora, la dimensione squadristica della memoria neofascista che ha eretto Predappio a proprio simbolo è stata più volte sottolineata anche nelle cronache giudiziarie che hanno riguardato elementi di spicco di Casa Pound come Gianluca Iannone.
L’intera operazione memoriale che riguarda quel luogo è stata quindi tenacemente costruita negli anni del revisionismo più aggressivo, quello di Pansa ma soprattutto quello avviato da una classe politica rinchiusa in un “paradigma vittimario” che, di fatto, ha progressivamente demolito il patto di memoria sul quale si è a lungo fondata la nostra cittadinanza costituzionale. Il tutto nel contesto di un forsennato “attacco alla storia” che spinge oggi il mondo a crearsi un passato di comodo per legittimare le proprie ansie e le proprie paure nel presente, costruendosi un passato “usa e getta” ma funzionale a reagire allo spaesamento e allo sradicamento di una realtà compiutamete globalizzata, dandosi una identità anche fittizia pur di legittimare così le proprie posizioni politiche.
Tutto questo è una sfida per gli storici. Ci sollecita a scendere nell’arena dell’uso pubblico della storia dove si combatte per una posta in gioco altissima: la trasmissione della conoscenza storica, la costruzione di un passato che recuperi complessità e spessore, proponendo la ricerca e le fonti come strumenti utili e indispensabili. Predappio è in questo senso certamente una sfida da raccogliere, dotandosi però di armi che risultino efficaci a partire dall’identificazione del “nemico”. Su Predappio non gravano solo i luoghi comuni e gli stereotipi tipici del passato “usa e getta”; c’è una narrazione neofascista che raccoglie le nostalgie di Salò ma è anche in grado di organizzare le pulsioni xenofobe e razziste che si agitano nelle visceri profonde del nostro paese e che – indipendentemente dalle singole appartenenze partitiche e politiche che coinvolgono settori del centrodestra, la Lega, Casa Pound e una vasta galassia neofascista - è oggi diventato culturalmente egemone nel nostro discorso pubblico, sollecitando attenzione e consensi anche in ambienti sociali tradizionalmente refrattari al fascismo vero e proprio. Predappio oggi è un luogo deputato a ospitare tutto quello che in Italia rimanda a una storia di sopraffazione e di esclusione, una storia fondata su valori come l’ordine, la gerarchia, la disciplina, la paura del diverso, la discriminazione razziale. Impegnarsi a Predappio e per Predappio, vuol dire confrontarsi con questi concetti che, nel loro insieme, sono la negazione dei principi di inclusione che orientano i valori della nostra Costituzione. Una mostra permanente va quindi ripensata in un contesto che è conflittuale, carico di tensioni, lontano dall’essere normalizzato e pacificato.
In questa dimensione agonistica, un altro degli avversari con cui ci si confronta nell’arena dell’uso pubblico della storia è il mercato, le cui presenza ingombrante e affiora prepotentemente delle posizioni del sindaco Frassineti sulle ragioni turistico-commerciali del progetto («Il primo cittadino deve fare gli interessi della sua comunità. E se questo significa convivere con il fantasma di Mussolini bisogna cercare di farlo al meglio e nel modo più redditizio») che portano a immaginare - accanto alla mostra - la costruzione di un ristorante e di «una esposizione di prodotti locali, fra cui il sangiovese, e un ufficio turistico». È vero, quasi ovunque il museo-merce e luogo di intrattenimento sta scalzando il museo-monumento, nel tentativo di assecondare i gusti di un pubblico nuovo più esteso, più variegato al quale si tenta di rapportarsi offrendo possibilità di autoriconoscimento, se non di protagonismo e di interazione. La necessità di confrontarsi con regole di mercato che assimilano la gestione di un museo a quella di un’azienda si è imposta già nell’ultimo ventennio del XX secolo innescando delle tendenze sulle quali richiamò a suo tempo l’attenzione Yannis Thanassekos, direttore della Fondation Auschwitz di Bruxelles: «il museo storico postmoderno eclissa l’interpretazione ragionata della storia a vantaggio della sensazione, della simultaneità, dell’immediatezza e dell’impatto. Così, anche il passato storico rientra nella cultura della messa in scena, dello spettacolare, dell’effimero». Considerazioni riprese dallo storico Francois Marcot, collaboratore del Musée de la Réesistance et de la Déportation di Besancon, che in quelle procedure vedeva un duplice rischio: per il pubblico, di essere ridotto a un esercito di consumatori; e per i valori del museo di passare «dalla sfera del civico a quella del mercantile [...] a meno che non si debba trovare proprio in questo il senso profondo del messaggio: essere cittadini, vuol dire essere consumatori». È un’ottica nella quale la visita al museo non serve tanto ad aumentare la conoscenza della storia quanto a offrire “un’esperienza”.
Che tipo di esperienza propone Predappio? Una “immersione totale” nel mondo del neo fascismo a cui segue poi la visita a una mostra che alle ragioni della storia giustappone quelle del mercato e dei consumi, all’insegna dei prodotti locali e del sangiovese?